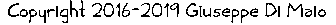|
Ci
sono invece giorni in cui io mi
incammino lungo le strade strette di questo paesino e cambio i miei
orizzonti.
Sento persone intorno a me che parlano di cose che ormai non
mi appartengono, non mi sorprendono.
Arrivo quasi al limitare delle
onde e mi siedo sempre rivolto verso il mare perché non
riesco a sopportare cose o persone che siano a distanze limitate.
L’uomo del bar ormai mi riconosce e senza che io lo debba
chiedere porta un caffè nero e acqua fredda.
Appoggia tutto
sopra il tavolo, senza parlare, senza necessità di
gentilezze inutili o vacui sorrisi di circostanza.
Mi rassicura questa
consuetudine.
Mi rassicura questo ripetersi di gesti e di persone che
quasi riesce a dare un senso alla tua assenza.
Come se fosse uno
spezzone di una pellicola consunta che si ripete
all’infinito.
Un film che spiega
l’attimo che segue
la devastazione, quando non hai ripreso a respirare e non sai ancora se
sei vivo.
È quasi un limbo dove il dolore è solo
un boato che da qualche istante si è perso
all’orizzonte e la disperazione arriva solo se il respiro si
fa profondo e smuove il sedimento dentro l’anima.
L’attimo prima della morte, o l’attimo dopo.
Così io bevo il mio caffè e poi riapro gli occhi
e lascio che lo sguardo si perda nuovamente dentro il mare.
Riprendo il
mio cercarti e non so dove tu sia.
Forse è proprio per
questo che guardo solo spazi immensi, enormi, sconosciuti: tu sei
dentro di me come una malattia ma non riesco mai a vederti in altri
luoghi, non riesco mai a sentire niente di più che grida,
che paura.
Cammino sopra un filo teso e non so dove cominci, non so
dove finisca, non so nulla di più di ciò che
vedo: un mare immenso e occhi che si perdono.
|