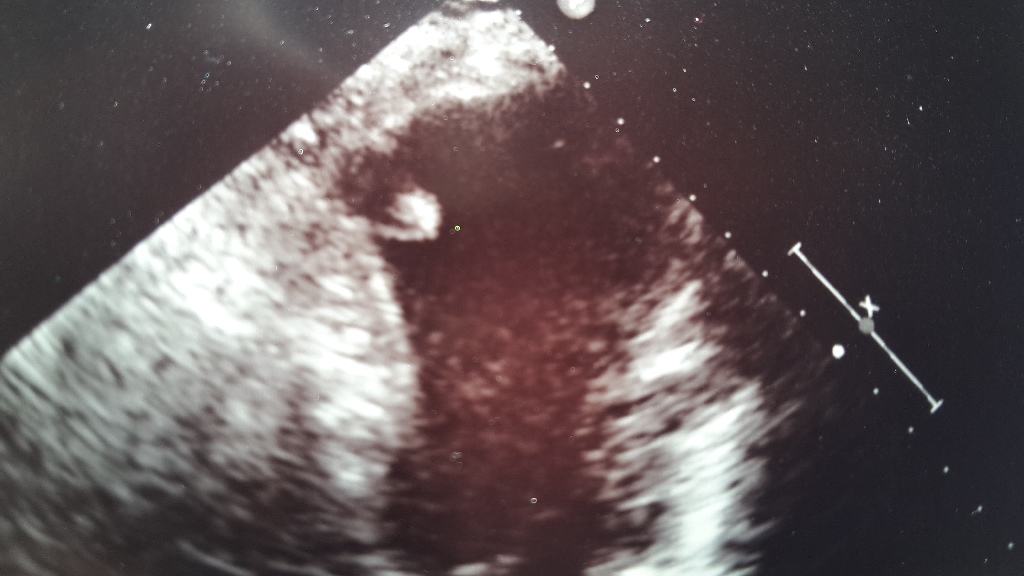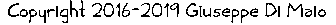|
Il
fotogramma successivo è totalmente nero e me ne rendo conto
solo ora.
Ora è "dopo" mentre il fotogramma nero è "prima"
e
questa certezza mi accompagna
mentre apro gli occhi.
È tutto confuso intorno,
sento delle voci ma faccio fatica a mettere a fuoco le immagini.
Sono sdraiato su un letto e di sicuro ci sono delle persone intorno a
me, ne
sento le voci ma non riesco a vederle, non riesco a muovere la testa,
non riesco a capire cosa dicono.
Riesco a muovere gli occhi ma le
immagini sono confuse, forse perché non ho gli occhiali,
forse perché sono morto.
È un faticoso riemergere da quel buio
totale, da quel primo fotogramma tutto nero che, ne ho la certezza
assoluta, è parte integrante della mia vita ma prima non lo
sapevo mentre ora l'ho visto e so di certo che appartiene a me, a un
passato che non so dire quanto sia lontano.
- È andato tutto bene - dice una voce che non saprei
localizzare.
Forse è di lato al mio letto o forse è dentro la
mia
testa.
- Tra poco togliamo il tubo endotracheale - dice ancora la stessa voce,
ma ora sembra che arrivi dall'alto, da sopra, anche se non so
esattamente dove sia sopra e dove sia sotto.
Il tubo endotracheale, già.
Lo sento ora, mi occupa la bocca, la gola e lo sento rigido dentro nel
mio
petto.
Mi avevano avvisato che con il tubo non sarebbe stato
possibile parlare perché viene inserito tra le
corde vocali ma non
potevo immaginare che "non poter parlare" volesse dire questo blocco
totale, questa
assenza assoluta, come se non avessi mai parlato in vita mia e non
sapessi cosa vuol dire emettere dei suoni.
Questa nuova consapevolezza del tubo mi mette un filo di ansia; avevo
paura di
questo momento, ho sempre avuto difficoltà con gli strumenti
che arrivano troppo in profondità nella mia bocca.
Questo nella vita precedente, perché c'è una vita
precedente e c'è un "ora" che è un luogo
sconosciuto, non perfettamente a fuoco, dove i processi cognitivi sono
lenti e graduali, dove il terrore abita a pochi passi da ogni pensiero.
Da poco sono uscito dal buio di quel fotogramma e ho imparato che ci
sono voci e tubi.
E che è andato tutto bene.
Non respiro.
È il tubo endotracheale, collegato a una macchina,
che respira per me e mentre galleggio su questo nuovo
baratro spaventoso, si avvicinano
delle persone, degli esseri indistinti, non so nemmeno quanti siano.
- Ora ti togliamo il tubo - dice qualcuno e qualcun'altro
aggiunge che tutto è andato talmente bene che sono
in grado di
estrarre il tubo dalla mia gola anche se sono passati solo venti minuti
dal risveglio.
Non mi dicono di soffiare, come nei telefilm e sono contento
perché non saprei davvero come fare.
Vedo le loro ombre accalcarsi su di me e poi sento
che afferrano qualcosa che è parte integrante della mia
bocca, del mio petto.
Non sembra un tubo, sembra piuttosto un bastone,
un pezzo di ferro infilzato dentro di me come una spada.
Non faccio in tempo a impaurirmi di questa nuova conoscenza che sfilano
da
me l'intruso, velocemente e senza dolore.
Tossisco immediatamente, come se l'aria fosse una massa gelatinosa che
d'improvviso ha invaso i miei polmoni.
È la prima tosse della
mia nuova vita, non proprio piacevole, ma riprendo a respirare.
Sto respirando e dunque sono vivo.
- Non è scontato sai che si possa togliere il tubo
endotracheale così presto - dice una voce femminile.
Riesco anche a vedere dei contorni, un'ombra che sta guardando qualcosa
di
fianco a me e poi passa dalla parte opposta del letto.
Con uno sforzo enorme
giro leggermente la testa e riesco a vedere la sua mano e una siringa
che inietta qualcosa in un tubicino.
Sento un'onda calda che parte dal collo e si propaga in tutto il corpo.
Morfina, credo.
- Che ore sono? - chiedo.
La voce è uscita a fatica, come se abitasse un luogo
profondo,
lontano.
Ha un suono leggero, un soffio di vento e non so se qualcuno
è riuscito a percepirla.
- Le sei di pomeriggio - dice la voce femminile e per un attimo mi
soffermo
sulla collocazione temporale.
Pomeriggio.
Quindi è oggi che mi hanno operato, poco più di
dieci ore fa.
Lo avevano detto: non mi avrebbero risvegliato dopo l'intervento.
Lo avrebbero fatto solo dopo la stabilizzazione dei valori.
- Ti sei svegliato da solo - continua a dire la voce. - È
inconsueto, ma molto positivo - precisa.
Ho gli occhi chiusi e ho cominciato a interrogare il mio corpo per
sapere
chi sono visto che sul "dove" ho qualche cognizione, ma non riesco a
vedere per avere conferma delle mie supposizioni.
Probabilmente sono
in terapia intensiva, in rianimazione, nel luogo dove rinascono le
persone a cui hanno fermato il cuore, tagliato il respiro e tolto il
sangue dalle vene. Sento
rumori e sento il mio cuore che batte, batte velocemente e lo fa in
sincrono con un rumore particolare che arriva dal fondo del mio letto,
una specie di
ritmo sincopato, come un batterista che usa le spazzole sul suo
rullante.
Non sento dolore, o almeno non c'è un dolore che emerge da
una
sensazione diffusa di indolenzimento, ma il respiro si ferma un attimo
prima di fitte che sento nel petto.
E poi probabilmente sono pieno di Morfina.
Alla mia sinistra si materializza all'improvviso il chirurgo che mi ha
operato ed è la prima persona che riesco a
vedere bene, che riconosco, nonostante la mia miopia e la situazione
oggettiva.
Mi guarda con un'espressione che non riesco a definire: pena,
soddisfazione, comprensione...
È venuto a salutarmi, a vedere come sto.
- È andato tutto bene - dice.
- Siamo riusciti a fare un buon lavoro, ora deve solo avere pazienza e
riposare - aggiunge.
Non so nemmeno se sono riuscito a dirgli grazie o se ho solo chiuso gli
occhi assaporando di nuovo la certezza che il peggio sia passato.
Forse mi sono addormentato o forse sono piombato in una condizione di
incoscienza perché ho solo l'immagine di ombre che ogni
tanto passano a
infilare aghi, cambiare le flebo, guardare i monitor che
improvvisamente hanno cominciato a fare rumori o forse sono io che ora
li sento mentre prima sentivo soltanto il battito del cuore.
Il mio cuore.
|